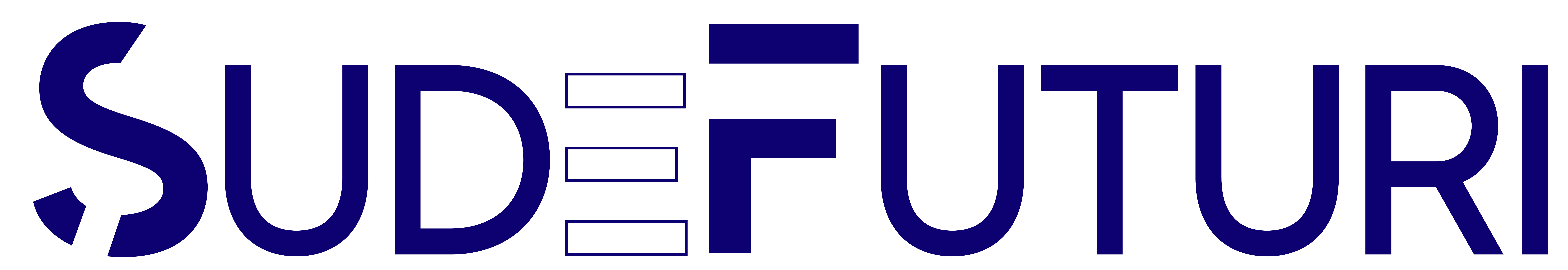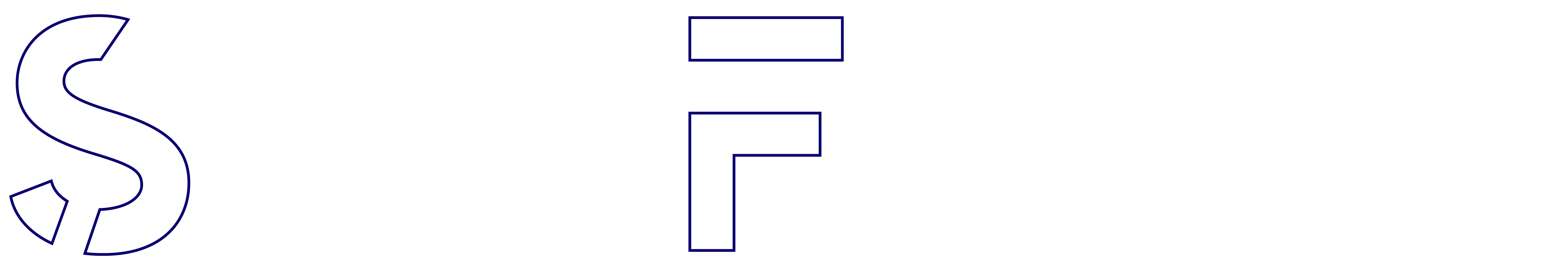L’atteggiamento ostile e fin troppo critico del Tycoon nei confronti della banca centrale rischia di rappresentare un ulteriore elemento di instabilità
I primi cinque mesi dell’Amministrazione Trump 2.0 rendono assai complesso trarre un bilancio della salute dell’economia americana, tenuto conto degli innumerevoli shock generati dalle politiche adottate. Spiccano, in particolare, quella doganale, che ha provocato una crisi finanziaria e un innalzamento dei rendimenti dei titoli del Tesoro a lunga scadenza, e quella fiscale che appesantirà una già traballante finanza pubblica.
In tale contesto, le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve (FED) assumono un ruolo chiave nello stabilizzare il ciclo economico e ridare fiducia a mercati e cittadini. Tuttavia, l’atteggiamento ostile e fin troppo critico del Tycoon nei confronti della banca centrale rischia di rappresentare un ulteriore elemento di instabilità. Si rende dunque necessario un inquadramento delle funzioni della FED e successivamente una messa a sistema dell’impatto delle sue scelte con le azioni del Tycoon per comprendere lo stato odierno dell’economia americana.
Trump vs Fed, il ruolo della Banca centrale
La Federal Reserve (FED) è la banca centrale degli Stati Uniti, istituita nel 1913 per gestire il sistema monetario e dei pagamenti in modo efficiente. Tra le sue funzioni principali rientrano la definizione della politica monetaria, regolando offerta di moneta e tassi di interesse, la supervisione del sistema finanziario e la gestione dei sistemi di pagamento. Autorizza, inoltre, la stampa e la distribuzione della valuta nazionale, ovvero il dollaro.
Il “Federal Reserve System” si articola in tre entità chiave: il Board of Governors, organo direttivo indipendente nominato dal Presidente; le dodici banche federali, che implementano le politiche, vigilano sul settore bancario e fungono da “banche del governo”; e il Federal Open Market Committee (FOMC), cioè l’organo decisionale per la politica monetaria.
Difatti, è il FOMC che si occupa di stabilire la quantità di moneta circolante disponibile nel sistema (offerta di moneta) attraverso specifici strumenti. Principalmente si adottano operazioni di mercato aperto che consistono nella vendita o nell’acquisto di Titoli di Stato. Nella prima ipotesi, la FED, vendendo i Bond ad altri soggetti, mira a ridurre la liquidità perseguendo, di fatto, una politica restrittiva volta a diminuire le tensioni inflattive. Nel secondo caso, invece, punta ad accrescere l’offerta di moneta per ottenere l’effetto opposto, portando avanti una politica espansiva, attraverso l’acquisto essa stessa di titoli e obbligazioni.
Trump vs Fed, il Federal Funds Rate (FFR)
In sintesi, dal punto di vista operativo,la Federal Reserve stabilisce un range target per il Federal Funds Rate (FFR), ovvero il tasso di interesse applicato tra le banche per i prestiti a brevissimo termine (overnight). Successivamente, regola la quantità di riserve nel sistema bancario per garantire che il FFR effettivo si mantenga all’interno di tale range.
Questo tasso rappresenta una misura del costo del denaro, dato che gli istituti di credito, per mantenere un margine di profitto, determinano i propri tassi sui prestiti a privati e imprese sulla base di questi costi di finanziamento. Ad esempio, una politica restrittiva, mirando a un aumento del Federal Funds Rate, comporterà un aumento dei tassi ai privati, rendendo inevitabilmente più difficile per alcune categorie di soggetti l’accesso al credito.
Dal 2022 in poi, il FFR ha subito una forte impennata che dal 0,25% lo ha portato all’odierno 4,5%, toccando picchi di oltre il 5%, mai registrati nei precedenti 10 anni. Questo andamento crescente riflette la volontà della FED di combattere l’elevata inflazione che ha caratterizzato l’economia americana nell’ultimo triennio, arrivando fino al 9,1% di giugno 2022. Come detto in precedenza, tassi elevati disincentivano consumi ed investimenti deprimendo la domanda aggregata e spingendo a ribasso il livello generale dei prezzi.
Trump vs Fed, il braccio di ferro
Oggi, però, il tasso di inflazione è del 2,4% e il tasso di crescita del PIL americano del primo quadrimestre 2025 è del -0,5%, ma i tassi sono ancora rimasti invariati. Per questo motivo Trump, dopo il suo insediamento, ha iniziato un braccio di ferro a distanza proprio con il Presidente della FED, Jerome Powell, accusandolo di star affossando volontariamente per questioni politiche l’economia americana, nonché minacciandolo di destituirlo dall’incarico se non avesse tagliato i tassi.
La tecnica del Tycoon è chiara: screditare l’operato della Banca Centrale agli occhi dell’opinione pubblica sperando nelle sue dimissioni o in un cambio di postura da parte del FOMC; anche perché non è chiaro se il Capo di Stato possa licenziare arbitrariamente il Presidente della FED, in quanto la legge stabilisce che i membri del Board of Governors possano essere rimossi solo per giusta causa legalmente riconosciuta.
Trump vs Fed, tensione alle stelle
Recentemente, la tensione tra i due è schizzata alle stelle dopo l’ultima riunione del FOMC del 18 giugno che ha confermato i tassi al 4,5%: decisione dettata dalla necessità di perseguire un’inflazione sotto al 2%, fondamentale in un quadro di elevata incertezza. Ovviamente la reazione del Tycoon non si fatta attendere: egli, oltre ad attaccare personalmente Powell, ha dichiarato di avere già pronta una lista di potenziali suoi sostituti.
Tuttavia diversi analisti economici sostengono che una mossa così autoritaria, ed in completo contrasto con il principio di indipendenza della FED, sia controproducente poiché rappresenterebbe un ulteriore elemento di instabilità che ricadrebbe prima sui mercati finanziari, danneggiando risparmiatori ed investitori in tutto il mondo; e successivamente inciderebbe negativamente sul rating dei Bond americani, considerati storicamente beni rifugio molto liquidi, che peraltro recentemente sono stati declassati ad AA1 dall’agenzia di rating Moody’s.
Perché la Fed non abbassa i tassi?
Indipendentemente dalle pressioni esercitate dall’esecutivo, la FED non ha intenzione di abbassare i tassi di interesse a causa di una serie di fattori e dati economici che destano preoccupazione tra le fila del FOMC. In primo piano spiccano nuovamente le conseguenze della politica doganale portata avanti a singhiozzo dall’amministrazione. Powell, sin dall’inizio, l’ha descritta come una manovra stagflazionistica che avrebbe potuto condurre ad un calo del tasso di crescita del PIL e, contemporaneiste, ad un possibile aumento dei prezzi, in quanto le imprese avrebbero scaricato l’effetto dei dazi sui consumatori.
Una situazione di questo genere arreca gravi danni al sistema economico proprio perché difficilmente risolvibile nel breve periodo: se la banca centrale abbassasse i tassi non farebbe altro che accrescere l’inflazione, erodendo il potere d’acquisto dei consumatori a tal punto da costringere le imprese a ridimensionare la propria produzione.
Trump vs Fed, la questione dei dazi
Sebbene il mercato del lavoro rimanga più che solido, caratterizzato da un tasso di disoccupazione del 4,2%, e il livello dei consumi degli americani sia in leggera crescita; è evidente che Powell voglia aspettare gli sviluppi della questione legata ai dazi prima di prendere una decisione definitiva. Trump ha comunicato di non voler prorogare la scadenza del 9 luglio sulle tariffe, anche perché dei 90 accordi commerciali promessi ne è stato siglato solamente uno, con il Regno Unito.
In data 12 luglio, infatti, il Presidente americano ha annunciato l’imposizione di dazi al 30% per l’Unione Europea a partire dal 1 agosto; tuttavia le trattative, seppur nuovamente arenate a causa delle eccessive richieste da parte degli USA, non sono ancora formalmente concluse: raggiungere un’intesa sarebbe fondamentale visto che gli scambi con l’Europa rappresentano il 43% del PIL mondiale. Una guerra commerciale, fomentata da ulteriori tariffe di rappresaglia europee, avrebbe il potenziale per innescare una recessione in America e nel Vecchio continente, data l’interconnessione delle due economie.
L’obiettivo del piano protezionista di Trump
In senso più ampio, il piano protezionista dell’amministrazione Trump si pone come principale obiettivo il miglioramento delle esportazioni nette, rappresentate dalla differenza tra il valore di esportazioni e importazioni di beni e servizi. Tuttavia, per adesso, l’import, a scapito della produzione interna, è addirittura aumentato rispetto agli anni precedenti. Difatti, a marzo molte aziende americane hanno acquistato scorte dall’estero, in previsione di un aumento dei prezzi su tali merci. Un fenomeno simile potrebbe accadere nuovamente, a maggior ragione se i negoziati con l’Europa dovessero fallire e i dazi venissero imposti ufficialmente (come pare) anche a Messico e Canada.
Alla luce di quanto detto, è possibile rilevare che sotto molti punti di vista le preoccupazioni del FOMC sono fondate. Come riportato recentemente dallo stesso Powell, senza lo shock tariffario provocato dal “Liberation Day”, la FED avrebbe già provveduto ad abbassare i tassi, stimolando la crescita economica per accentuare l’effetto moltiplicativo degli ingenti finanziamenti infrastrutturalidell’amministrazione Biden.
Il vero obiettivo di Trump
Secondo le previsioni della FED, sono ancora plausibili due tagli entro la fine del 2025: alcune proiezioni economiche evidenziano che la crescita del PIL nei successivi trimestri tornerà al 3%, scacciando, così, l’ipotesi stagflazione. Se ciò dovesse accadere, e l’inflazione non dovesse salire a causa dei dazi, a fine settembre potrebbe verificarsi il primo “FFR cut”. Una manovra espansiva, in primis, incrementerebbe consumi ed investimenti privati, stimolando settori chiave per l’economia americana, come quello immobiliare; in secondo luogo, inciderebbe positivamente sulle finanze pubbliche.
È necessario ricordare che ad oggi il debito pubblico USA ammonta a 28,9 mila miliardi e il rapporto con il PIL è del 97,8%. In aggiunta, gli Stati Uniti non registrano un avanzo primario da circa 20 anni. Ciò significa che, per un ventennio, la differenza tra entrate ed uscite pubbliche, al netto degli interessi sul debito, è sempre stata negativa. Per finanziare questo deficit sistematico, il Governo americano ha contratto ulteriore debito portando la spesa per interessi passivi pagati sui titoli di stato a 881 miliardi di dollari.
Lo shock doganale e i Treasury bond
Addirittura, dopo lo shock doganale, il rendimento dei “Treasury Bond” decennali era salito fino al 4,5%: trend dovuto principalmente ad una massiccia vendita osservatasi nel mercato finanziario che ne ha fatto calare la quotazione. Questo fenomeno, oltre ad essere un chiaro segnale di incertezza legato all’economia americana, ha aumentato ancora di più il deficit pubblico, in parte compromettendo la solvibilità del Paese.
In questo senso, un taglio ai tassi di interesse compiuto dalla FED permetterebbe, almeno in linea teorica, un alleggerimento della spesa per interessi, grazie a tassi più bassi sui nuovi Bond emessi. Inoltre, un lieve aumento dell’inflazione avvantaggerebbe le casse federali come conseguenza della riduzione del valore reale del debito.
Trump vs Fed, le finanze pubblico problema strutturale
Certamente, le finanze pubbliche continueranno a rappresentare un problema strutturale, soprattutto considerando la linea politico-economica della corrente MAGA, il cui obiettivo principale consiste nel ritornare a un periodo di boom economico simile a quello che caratterizzò l’economia statunitense dal Dopoguerra fino agli anni ’70. A ciò, in coerenza con la narrazione propagandistica trumpiana, si aggiunge una radicale manovra fiscale, approvata con una maggioranza risicatissima in data 3 luglio, che prende il nome di “Big Beautiful Bill”.
In sintesi, la riforma taglierà ingentemente le tasse, ridimensionerà i programmi di sostegno per i cittadini a basso reddito ed aumenterà i fondi per la sicurezza dei confini;così facendo si registrerebbero da un lato, tagli alla spesa per 1.397 miliardi di dollari, dall’altro un’aggiunta di 3,4 trilioni di dollari al deficit federale in 10 anni. L’introduzione del “Big Beautiful Bill” da parte dell’amministrazione Trump si profila meno come una strategia puramente economica e più come una mossa di propaganda politica. Questa riforma fiscale mira a consolidare il consenso attorno a Trump, presentando un “boom economico” come diretta conseguenza delle sue politiche, anche di quelle più controverse e criticate a livello mondiale come quella tariffaria.
Dalla “Trumpenomics”, dunque, si può dedurre un principio cardine che ha contraddistinto la carriera politica del Tycoon: le percezioni contano più dei fatti. L’idea di un’economia più solida, sostenuta da politiche espansive, risulta essere un obiettivo da perseguire, indipendentemente dalle conseguenze economiche provocate da esse. In contrapposizione a questa filosofia si trova proprio la FED, il cui mandato si fonda sulla stabilità a lungo termine, rendendola l’ultimo baluardo contro una narrazione economica che privilegia il consenso immediato a discapito della salute finanziaria del Paese sul lungo periodo.
Fonte Geopolitica.info