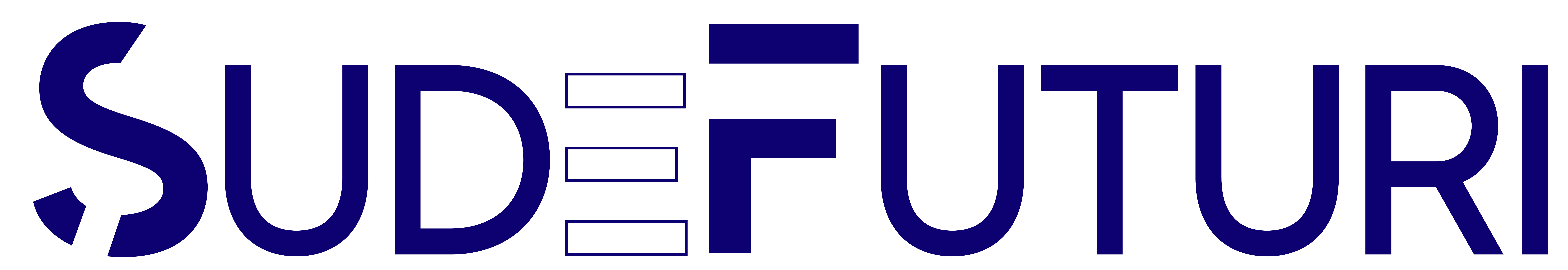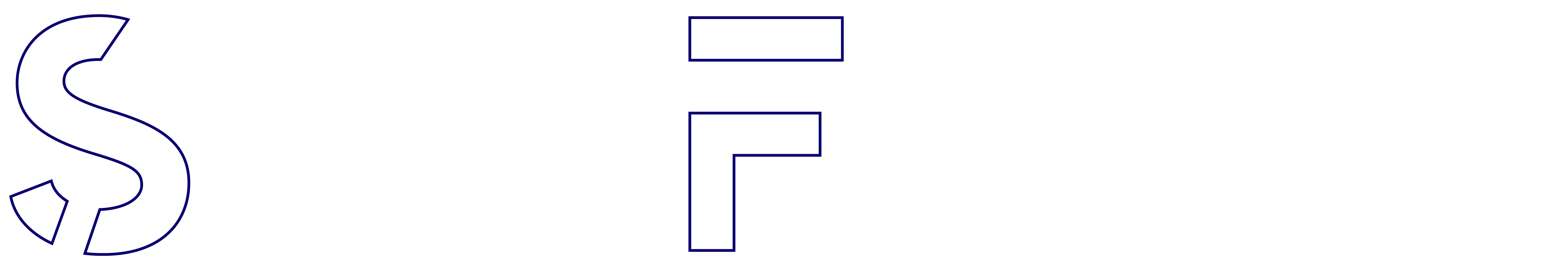La crisi nella Striscia di Gaza, aggravata dal riaccendersi delle operazioni militari israeliane e dal blocco degli aiuti, apre interrogativi cruciali sul ruolo della Gaza Foundation, tra esigenze di sicurezza e rischio di strumentalizzazione politica
La Striscia di Gaza attraversa una delle fasi più drammatiche della sua storia recente. Oltre due milioni di persone risultano intrappolate in un contesto segnato da una crisi umanitaria estrema, in cui la cronica carenza di cibo, acqua potabile e servizi sanitari di base sta evolvendo verso scenari di carestia conclamata. La situazione, già gravissima dopo quasi venti mesi di guerra, ha conosciuto un ulteriore deterioramento a partire dal 18 marzo 2025, quando Israele ha ripreso operazioni militari su larga scala, ponendo fine a una fragile tregua durata due mesi e con l’inserimento di un nuovo attore: la Gaza Humanitarian Foundation.
La rottura della tregua e il blocco degli aiuti nella Striscia di Gaza
Dopo mesi di intensi combattimenti, il 15 gennaio 2025 era stata raggiunta una tregua tra Israele e Hamas, mediata principalmente da Egitto, Qatar e Stati Uniti. L’accordo aveva permesso una parziale ripresa delle attività delle agenzie umanitarie nella Striscia, con il ritorno limitato di convogli umanitari e una fragile riduzione delle ostilità. Tuttavia, la tregua si è interrotta bruscamente il 18 marzo 2025, quando Israele ha avviato l’operazione militare denominata “Gideon’s Chariot”.
Secondo l’Ufficio del Primo Ministro israeliano, la decisione sarebbe motivata dalla necessità di “smantellare le ultime cellule armate di Hamas” presenti nella Striscia e di ottenere il rilascio di circa 59 ostaggi israeliani ancora detenuti a Gaza, di cui meno della metà ritenuti in vita. Tuttavia, diversi osservatori internazionali, come International Crisis Group (ICG), ritengono che Israele si sarebbe ritirato dal tavolo negoziale per la seconda fase dell’accordo, che avrebbe dovuto portare al cessate il fuoco definitivo e al rilascio progressivo dei prigionieri.
L’operazione “Gideon’s Chariot” ha comportato un’intensificazione dei bombardamenti su diverse aree di Gaza. Solo nelle prime ore, oltre 400 persone sarebbero rimaste uccise, mentre colpi di artiglieria hanno colpito aree densamente popolate, edifici residenziali e strutture utilizzate come rifugi per sfollati. La ripresa delle operazioni militari ha avuto ripercussioni immediate anche sul piano umanitario. I principali valichi di ingresso degli aiuti, Kerem Shalom e Rafah, sono stati quasi totalmente chiusi o soggetti a restrizioni severe.
Gaza, meno del 15% degli aiuti alimentari necessari per la sopravvivenza minima
Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (OCHA), dalla seconda metà di marzo 2025 è entrato nella Striscia meno del 15% degli aiuti alimentari necessari per la sopravvivenza minima della popolazione. Il World Food Programme (WFP) ha segnalato livelli di malnutrizione acuta fra i bambini sotto i cinque anni superiori al 30%, definendo la situazione “estremamente preoccupante”.
Secondo l’Ufficio del Primo Ministro israeliano, la decisione sarebbe motivata dalla necessità di “smantellare le ultime cellule armate di Hamas” presenti nella Striscia e di ottenere il rilascio di circa 59 ostaggi israeliani ancora detenuti a Gaza, di cui meno della metà ritenuti in vita. Tuttavia, diversi osservatori internazionali, come International Crisis Group (ICG), ritengono che Israele si sarebbe ritirato dal tavolo negoziale per la seconda fase dell’accordo, che avrebbe dovuto portare al cessate il fuoco definitivo e al rilascio progressivo dei prigionieri.
La Gaza Humanitarian Foundation: origine, finalità e criticità operative
Nel complesso quadro del conflitto israelo-palestinese, il tema della gestione degli aiuti umanitari ha assunto nel 2025 un significato ancor più delicato, anche per le sue implicazioni politiche e strategiche. In questo contesto si colloca la nascita della Gaza Humanitarian Foundation (GHF), istituita formalmente nel febbraio 2025 come fondazione statunitense, con sede legale negli Stati Uniti, ma con legami stretti con l’apparato governativo israeliano.
La fondazione è stata presentata dalle autorità statunitensi e israeliane come uno strumento per impedire che gli aiuti umanitari finiscano nelle mani di Hamas, già designato come organizzazione terroristica da Israele e dagli Stati Uniti. Fin dalle prime settimane, il funzionamento della GHF ha sollevato numerose criticità, segnalate da operatori umanitari e osservatori indipendenti, come Human Rights Watch (HRW) e OCHA.
La distribuzione degli aiuti avviene prevalentemente in zone sotto stretto controllo militare israeliano. L’accesso è subordinato a procedure complesse: secondo testimonianze raccolte da Human Rights Watch, Amnesty International e inchieste di stampa internazionale (New York Times, Guardian, Al Jazeera), i civili affrontano lunghi controlli di sicurezza, code interminabili e screening biometrici, spesso in condizioni aggravate dal contesto bellico.
Più sorveglianza e controllo che soccorso delle popolazioni
Tali procedure hanno alimentato la percezione che la GHF operi più come uno strumento di sorveglianza e controllo dei flussi umanitari, piuttosto che come un ente neutrale volto esclusivamente al soccorso delle popolazioni civili, tema sollevato anche dalle dimissioni del suo direttore esecutivo, Jake Wood, il 22 febbraio.
Un altro degli aspetti più controversi legati alla Gaza Humanitarian Foundation riguarda il rischio che il nuovo sistema di distribuzione degli aiuti umanitari possa essere uno strumento politico finalizzato non solo a contenere Hamas, ma anche a modificare la geografia umana della Striscia di Gaza.
Al centro delle denunce degli organi già menzionati vi è il concetto di “food cage” o “gabbia alimentare”: una situazione in cui la fame viene usata come leva per costringere la popolazione a concentrarsi in zone ben delimitate e sotto stretto controllo militare. Tale strategia troverebbe eco in dichiarazioni di alcuni leader israeliani, tra cui il Primo Ministro Benjamin Netanyahu, che nell’aprile 2025 ha menzionato la possibilità di creare una “zona sterile” nel sud della Striscia come preludio a un esodo verso l’Egitto.
A tal riguardo, il diritto internazionale umanitario vieta lo spostamento forzato della popolazione civile, se non per ragioni legate alla sicurezza degli stessi civili o a esigenze militari imperative. La pratica della “gabbia alimentare” solleva dunque interrogativi circa la sua compatibilità con l’articolo 49 della IV Convenzione di Ginevra del 1949, che proibisce deportazioni e trasferimenti forzati di civili in territori occupati.
Gaza, cosa dice la convenzione per la prevenzione e repressione del genocidio
Dal punto di vista giuridico, la questione investe norme fondamentali del diritto internazionale: la Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio del 1948 non limita la nozione di genocidio agli atti di uccisione diretta, ma vi include anche la creazione deliberata di condizioni di vita destinate a provocare la distruzione fisica, anche parziale, di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.
In quest’ottica, come evidenziato nel rapporto Anatomy of a Genocide (marzo 2024) della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati, privazioni sistematiche di cibo, cure mediche o riparo, così come lo sfollamento forzato, possono rientrare nella definizione di genocidio qualora risulti provato l’elemento soggettivo dell’intento genocida.
All’interno di questo quadro, il ruolo degli Stati Uniti appare particolarmente complesso. Washington continua a presentarsi come il principale sostenitore di iniziative umanitarie nella Striscia, incluso il modello di distribuzione affidato alla Gaza Humanitarian Foundation (GHF). D’altro lato, però, gli Stati Uniti sono anche il principale alleato strategico e militare di Israele, sia sul piano politico sia per quanto riguarda forniture di armamenti e supporto diplomatico nelle sedi internazionali.
Questa duplice posizione alimenta interrogativi sulla possibile corresponsabilità statunitense rispetto a eventuali violazioni del diritto internazionale commesse da Israele.
Gaza e il ruolo dell’Europa: una risposta frammentata
Accanto agli Stati Uniti, anche i Paesi europei si trovano a dover bilanciare principi giuridici, pressioni politiche e interessi economici nelle loro reazioni alla crisi di Gaza. Da un lato, Francia, Spagna, Irlanda, Norvegia e, più recentemente, Germania hanno assunto posizioni più critiche verso l’operazione israeliana a Gaza, denunciando l’elevato numero di vittime civili e le restrizioni agli aiuti umanitari.
Francia e Regno Unito hanno sospeso, almeno in parte, negoziati commerciali o licenze di esportazione militare verso Israele. Inoltre, alcuni Paesi europei, come Spagna e Malta, hanno annunciato il possibile riconoscimento dello Stato palestinese, pur consapevoli del carattere prevalentemente simbolico di tale gesto in assenza di sviluppi concreti sul terreno; anche la Francia aveva ipotizzato tale possibilità, successivamente accantonata in seguito all’aggravarsi del contesto regionale con l’avvio del conflitto tra Israele e Iran.
L’Ue e la revisione delle clausole sui diritti umani
Sul piano istituzionale, l’Unione Europea ha avviato una revisione delle clausole sui diritti umani contenute nell’Accordo di Associazione del 1995 con Israele. Ciò potrebbe tradursi in misure restrittive, fino alla sospensione parziale dei privilegi commerciali garantiti a Israele, anche se la mancanza di unanimità (con Paesi come Ungheria e Repubblica Ceca contrari) rende improbabile una sospensione totale. Alcuni Stati, come la Svezia, ipotizzano sanzioni individuali contro membri del governo israeliano coinvolti nella politica di insediamenti o in dichiarazioni ritenute incitanti alla violenza.
Dall’altro lato, Austria, Polonia, Ungheria e parte dello stesso governo tedesco mantengono un sostegno quasi incondizionato a Israele e hanno dichiarato di non voler rispettare eventuali mandati di arresto internazionali nei confronti di Netanyahu o altri esponenti israeliani, qualora emessi dalla Corte Penale Internazionale. Ne risulta un’azione europea frammentata, spesso incapace di tradurre le dichiarazioni politiche in misure concrete. Eppure, il forte legame economico tra UE e Israele — con l’Europa che rappresenta circa un terzo del commercio estero israeliano — costituisce uno strumento potenzialmente significativo di pressione.
Il confine tra aiuto umanitario e interesse strategico
La crisi nella Striscia di Gaza mostra come il confine tra aiuto umanitario e interesse strategico sia oggi più sfumato che mai. La nascita della Gaza Humanitarian Foundation, le restrizioni imposte ai convogli, e il controllo crescente sui flussi di beni essenziali rendono evidente che anche l’umanitario, in contesti ad alta intensità geopolitica, non sfugge alla logica delle leve di potere.
La gestione degli aiuti nella Striscia, lungi dall’essere un semplice strumento di soccorso, si configura come un nodo critico dove convergono sicurezza, diplomazia, diritto internazionale e geografia del conflitto. In questo senso, Gaza diventa non solo un teatro di emergenza, ma anche un laboratorio di nuove forme di governance nei conflitti asimmetrici contemporanei.
Ciò che resta sul tavolo, per la comunità internazionale, non è soltanto la sfida di rispondere a una crisi in atto, ma di ridefinire i parametri stessi attraverso cui si misura l’umanitario in contesti bellici complessi. Perché quando il soccorso diventa selettivo, condizionato o strumentalizzato, non è solo l’etica a essere in gioco, ma la tenuta stessa dell’ordine giuridico internazionale.
Fonte Geopolitica.info